TORNA ALLA HOME DEL MUSEO RYOLO
Milazzo, la tutela del
mare viene da lontano
di Massimo Tricamo e Salvatore Salmeri *
* volontari del Museo Etnoantropologico e Naturalistico
“Domenico Ryolo”
Necessità improrogabile di salvaguardare le vaste praterie di posidonia ed il novellame delle nostre coste di Levante da pescatori senza scrupoli. A lanciare l’appello non è il biologo Carmelo Isgrò, né tantomeno il presidente dell’Area Marina Protetta, ma un giovane avvocato destinato ad una brillante carriera giuridica. Un legale con una spiccata vocazione ambientalista, molto sensibile alla tutela dell’ecosistema marino. Francesco Maria Pisani, questo il suo nome, non è però un cittadino della Milazzo 2.0, quella degli smartphone e della realtà aumentata che al Mu.Ma. di Carmelo Isgrò fa rivivere il capodoglio Siso. Francesco Maria Pisani visse infatti a cavallo tra Sei e Settecento. Intorno al 1678 gli sfuggì per un soffio l’elezione a «sindaco e procuratore» della Città di Milazzo, ma non si diede per vinto, lasciando anzi al nuovo sindaco un memoriale in cui suggeriva in pochi punti quanto a suo parere andava realizzato per arrecare benefici alla collettività. A partire dalla tutela della biodiversità marina che da sempre ha contraddistinto i nostri fondali.
Nella sua relazione, custodita tra le antiche carte
d’archivio dei marchesi Proto giunte da qualche mese al Museo Etnoantropologico
e Naturalistico “Domenico Ryolo” di Milazzo, il Pisani si scagliava contro una
quindicina di pescatori locali, che con la loro condotta senza scrupoli
mettevano a repentaglio le specie ittiche, le praterie di posidonia, i già
magri bilanci dei pescatori onesti e persino le finanze comunali. All’origine
di questi inconvenienti l’impiego scriteriato dell’àngamo, uno dei “mestieri” - così si chiamano ancor oggi a
Vaccarella gli arnesi da pesca - più devastanti per i fragili equilibri marini.
Malgrado fosse conosciuto già nel primo Cinquecento - il matematico
messinese Francesco Maurolico lo descrive con dovizia di dettagli in un suo
manoscritto dato alle stampe a fine Ottocento - l’angamo venne introdotto a
Milazzo soltanto negli anni Settanta del Seicento per iniziativa di Giuseppe
Fazio, un pescatore del comprensorio cui il Pisani non mancava d’indirizzare
parole tutt’altro che lusinghiere, riconoscendogli tuttavia abilità non comune nel
procacciarsi benefici sostegni attraverso omaggi mirati: «per quattro scorfane
ebbe molti protettori».
Lo sconsiderato impiego dell’angamo, che a Milazzo ebbe immediatamente larga diffusione, impoveriva il mare e di conseguenza i pescatori onesti e gli introiti del tributo comunale, la gabella del pesce, il cui gettito non riusciva più ad ascendere alle 400 onze garantite dalle pesche ubertose registratesi sino al 1667, prima cioè dell’introduzione dello stesso angamo per opera di Giuseppe Fazio.
Costituito da due archi lignei di circa 3 metri di lunghezza
ciascuno, uno dei quali - quello destinato ad adagiarsi sul fondale marino -
rivestito di ferro, l’angamo era provvisto d’una rete a maglie “spesse”, ossia
fittissime, oggi comunemente denominata “manica”. L’accurata descrizione del
“mestiere” da parte del Pisani è accompagnata dall’elencazione degli
inconvenienti legati a questo tipo di pesca, eseguita nelle ore notturne. Ed è
qui che il giovane giurista milazzese manifesta in tutta evidenza la sua anima
ambientalista: «con questo nemico instrumento, manegiato da due sole persone,
vien raso il suolo e rovinata e strappata l’elica, tirandosi in detta rete
milioni di pesci di tutte specie, de’ quali il più grosso è come una mosca».
L’angamo, arando il fondale, faceva razzia di novellame, intrappolato nella
rete a maglie fittissime, strappando via nel contempo l’elica, italianizzazione
del termine dialettale “àlica” impiegato ancor oggi dai pescatori di Vaccarella
per indicare la posidonia oceanica. Gli stessi pescatori vaccariddòti chiamano
invece “nurìmi” il novellame, che il Pisani italianizzava in “norrime”. Ma c’è
di più. Ad essere in pericolo non erano soltanto microscopici pesciolini, ma
anche un numero spropositato di uova: «possiamo
[altresì] argomentare l’infinità degli ovi non ancor nati che rimangono
destrutti. Anzi, il più delle volte resta così disfatta e strappata l’elica che
le madri [dei pesci] non hanno luogo proportionato di vomitar gli ovi e vadono
a cercarlo altrove. Si che (…) va in rovina la pescaggione».
Le argomentazioni del Pisani si spingono sino ad illustrare
le qualità benefiche della posidonia oceanica, allora abbondante lungo le coste
del levante milazzese. Allo scopo di sfuggire alla voracità della “pulce”, un
predatore abituato a vivere lontano dai fondali, le «madri di qualunque specie
di pesci» deponevano le proprie uova tra la rigogliosa vegetazione della
posidonia, che offriva un confortevole e sicuro «asilo in cui nascono in
grandissimo numero i pesci». Se fosse vissuto oggi il Pisani avrebbe additato le
praterie di posidonia oceanica
come ottime aree di nursery per
centinaia di specie ittiche.
Ed ecco che emerge l’anima politica del giovane giurista, il
quale invoca provvedimenti normativi a tutela del mare, in analogia a quanto
già fatto nel Regno di Sicilia per la caccia delle lepri, inibita da marzo a
luglio. Il Comune di Milazzo avrebbe dovuto fare la propria parte, richiedendo
al viceré la proibizione della pesca con l’angamo e la distruzione degli
esemplari esistenti: a Milazzo se ne contavano già 15. In alternativa sarebbe
bastato dirottare questo tipo di pesca dove la posidonia scarseggiava, ossia
sul versante di Ponente, dal Tono sino ad Oliveri, salvaguardando così le
praterie di Levante a ridosso del Porto e quelle che al Promontorio erano
dislocate dalla Croce di Mare sino alla Lanterna della Baronia.
 |
Sfogliando la bibliografia in materia, pare che un divieto
fosse stato stato introdotto nel Regno di Sicilia, ma forse limitatamente al
Siracusano. Tanto Tommaso Gargallo (Memorie
Patrie per lo ristoro di Siracusa, tomo secondo, Napoli 1791, pag. 169)
quanto l’avv. Avolio (Delle leggi
siciliane intorno alla pesca, Palermo 1805, pag. 196) ne lamentano però il
mancato rispetto, con gli angami che sterminavano flora e fauna del porto
aretuseo. Nel 1816 il Duca d’Ossada Francesco Carlo D’Amico, nel suo
monumentale volume sulle tonnare siciliane, ribadiva la necessità di mettere al
bando questi arnesi da pesca, ancora oggetto di lamentele e proposte nei primi
decenni postunitari. La sottocommissione del Compartimento Marittimo di
Messina, comprendente anche Milazzo, intorno al 1870 chiedeva al Governo di
proibirli in vista della redazione del progetto di legge sulla pesca (La pesca in Italia, vol. I, parte I,
Genova 1871, pag. 584). Istanza ribadita in una pubblicazione del 1887 in cui
dal Messinese si rilevava come fossero gli stessi pescatori ad additare
l’angamo quale «rovina del mare» (Notizie
sulla pesca marittima in Italia in Annali di Agricoltura, Tip. Eredi Botta,
Roma 1887).
Questa svogliata condotta del legislatore nei secoli sembra
dare ragione a chi oggi a Vaccarella evidenzia la sporadicità dell’uso di
questo arnese da pesca, tale dunque da essere tollerato dalle autorità. «Si
pescava con l’angameddu saltuariamente, i pescatori erano ben consapevoli dei
rischi che comportava tale “mistèri”, cui si ricorreva quando giungeva un’ordinazione
di “anzùni” (paguri) impiegati per calare la “piliùsa” oppure par pescare con
le lenze “a lùvari”. Con l’angamèddu venivano catturati anche gamberetti
verdolini ottimi per la frittura», ricorda Antonino Salmeri, classe 1938, che
spesso coadiuvava il suocero Francesco Cutugno, tra i più esperti “marinari”
della Tonnara del Tono. «A volte l’angameddu veniva impiegato come una sorta di
sciabica: ancoravano la barca e lo tiravano a sé a forza di braccia. Usavano
lunghe cime, chiamate “calamènti”, tirandolo a bordo dell’imbarcazione».
Salmeri custodisce ancora l’angamèddu del suocero: «per me è una reliquia
preziosa, mi fa sentire vicino a mio suocero. Ma soprattutto l’ho custodito con
l’auspicio che un giorno possa fare bella mostra nel Museo della Pesca e delle
Tradizioni Marinare che l’Amministrazione comunale ha intenzione d’istituire
nell’ex Asilo Calcagno, affinché serva da monito alle future generazioni
sensibilizzandole ad un uso rispettoso e decoroso del nostro mare».
L’angameddu di Salmeri - un altro esemplare impiegato sino
agli anni Sessanta ci fu mostrato qualche anno fa dal pescatore milazzese
Salvatore Della Candelora - presenta il consueto aspetto rudimentale. I due
semicerchi in ferro e legno, ancora diffusi nella prima metà del Novecento,
hanno ceduto il testimone a due tubolari a forma di U che s’incontrano ad
angolo retto, così come i suddetti semicerchi. Il telaio metallico è opera del
milazzese Franco Sarà, mentre la manica venne allestita dal citato tonnaroto
vaccariddòto Francesco Cutugno.
***
Iesus etc.
Nota di ciò che pensava
pratticare il Dottor Don Francesco Maria Pisani se fosse stato eletto sindaco
della Città di Milazzo e dovrebbe farlo [adesso] la persona in cui è caduta
l’elezzione.
(…) Si devono proibire gli
angami introdotti in questa Città da un pescator forastiere chiamato Giuseppe
Fazzio, che non avendo potuto fermar il piede nella marina di Palermo capitò in
Milazzo e per quattro scorfane ebbe molti protettori. Anzi, col suo esempio,
molti angami si fabricarno, che sono la destruzione del patrimonio della Città,
dell’abondanza e della maggior parte de’ cittadini. Li quali vivevano con
l’arte del pescare ed ora periscono di fame e son costretti andar a pescare in
altri mari, con molto disagio e spesa e con perdita delle gabelle e
specialmente di quella del pesce, la quale nell’anno 1667 fu liberata per onze
400, e dopo, introdotti gli angami, andò minorando, talché mai più si vidde nel
primo stato, come si scorge dai libri del detentore.
E per conoscersi il
danno che si riceve dagli angami si deve sapere che le madri di qualunque
specie di pesci, volendo per natural instinto conservar la generazione e
temendo gliela devasti un animaletto chiamato polce, che sta su le ripe,
spruzzano gli ovi (volgarmente norrime) su le frondi dell’elica che si nasconde
in molte secche sott’acqua e da qualunque parte remota vengono a trovarla come
un asilo in cui nascono in grandissimo numero i pesci. Ed in questo mare che
riguarda l’Oriente si trovava una special abondanza per la moltitudine
dell’elica e si provedeva non solo questa Città di Melazzo, ma tutte quelle
della Comarca.
E pure tutto questo
apparato della natura lo distruggono gli angami, già cresciuti al numero di 15,
li quali battono ogni notte il mare nella forma sequente.
Si forma l’angamo di
due archi di legno che girano 12 palmi ogn’uno, il primo de’ quali, posando in
terra, è foderato al di sotto di ferro ed al di sopra porta molti piombi per
peso. Su la barca di questo primo s’alza in aria il secondo arco e tutti dui
son vestiti in forma di grotta d’una forte e densa rete, quale si stende dalla
bocca altri quattro passi in circa. Con questo nemico instrumento, manegiato da
due sole persone, vien raso il suolo e rovinata e strappata l’elica, tirandosi
in detta rete milioni di pesci di tutte specie, de’ quali il più grosso è come
una mosca. E fra questi pescano due o tre tarì al più di pesci buoni da potersi
mangiare e spesse volte ancora meno di grani dieci. Dal che possiamo
argomentare l’infinità degli ovi non ancor nati che rimangono destrutti. Anzi,
il più delle volte resta così disfatta e strappata l’elica che le madri non hanno
luogo proportionato di vomitar gli ovi e vadono a cercarlo altrove. Si che si
perde anco il guado e va in rovina la pescaggione. E pure con tanta puoca
economia, anzi con manifesta cecità, si permette ogni notte ed in tutti i tempi
l’esercizio dell’angamo, quando che vediamo con ottima providenza proibito
dalle prammatiche la caccia de’ lepri ed altri, dal primo di marzo sino a primo
d’agosto, ed in tutti i tempi è proibito il cacceggiare con reti. E nondimeno
con questi non si nutriscono le città, come succede con la pescaggione, ma si
vieta la caccia per non mancar il diletto.
Perciò, potendo i
Signori Ministri informarsi da persone prattiche in Palermo e saper questa
verità, si potranno compiacere ordinare che nessuno ardisca di pescare con
angamo e si disfacessero li già fatti, tanto più che la spesa è di pochi tarì.
O almeno fossero proibiti con rigorose pene di poter pescare in tutto quel mare
che riguarda l’Oriente e solo sia lecito pescar con detto angamo nel mare di
Ponente, incominciando dal Tono ad andar verso l’Oliveri, dove per non esservi
elica non si patirebbe l’antedetto disordine ed averanno 18 miglia da poter
pescare. Benché il più accertato sarebbe proibirli à fatto, per non sogiacersi
alle contravenzioni che potrebbero commettersi, con la protezione de’ più
potenti, tanto più che è facenda di notte [Archivio Storico “Bartolo Cannistrà” del Museo
Etnoantropologico e Naturalistico “Domenico Ryolo” di Milazzo, fondo marchesi
Proto, manoscritto “Eredità di Don Paolo Proto - vol. II”, ff. 379r, 379v,
380r].
Antonino Salmeri lega «'u muggiunàru», l'apertura della fitta rete da cui si svuotava quanto catturato dall'angamèddu.
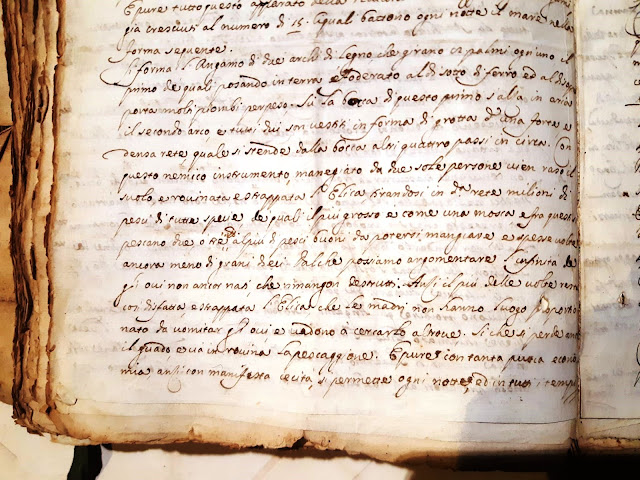




Commenti
Posta un commento